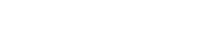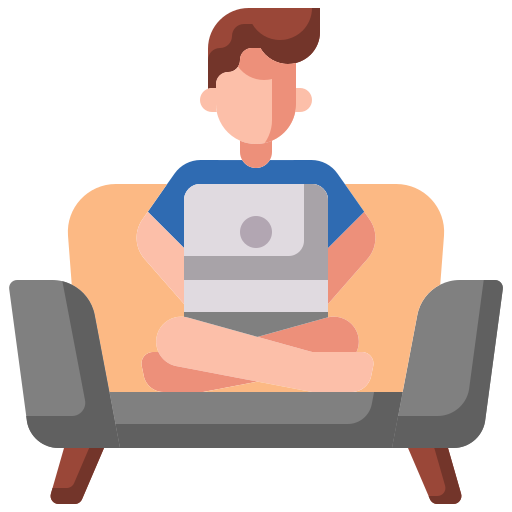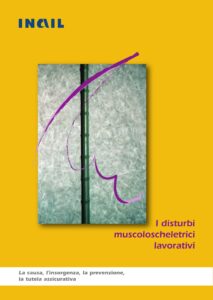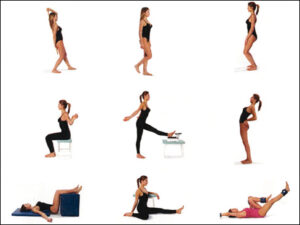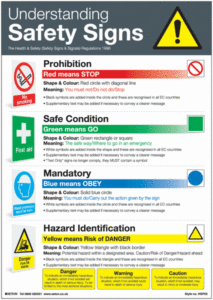Archivi
Achille Venzaghi
Luigi Locatelli
(Bergamo, 1904 – Bologna, 1984)
Achille Venzaghi
Olio su tela, cm. 130 x 90
Nato nel 1851 da Giuseppe, orefice e dettagliante in tessuti, e da Carolina Bossi, Achille Venza-ghi aprì nel 1871 una fabbrica dove si producevano scialli di cotone, in seguito diventata la socie-tà Bossi, Restelli & C., dal nome di due zii. Nel 1881 fondò con i fratelli Luigi e Pietro la ditta Fratelli Venzaghi di Giuseppe, con sede in uno stabile di corso XX Settembre affittato dal cotoni-ficio Carlo Candiani. In seguito la ditta si trasferì in via di Circonvallazione (ora via Mazzini) dando luogo ad un imponente complesso con reparti di filatura, tessitura meccanica di stoffe di cotone tinte e colorate per abiti da uomo, jacquard, tele cotone per pantaloni, ritorcitura e apparec-chiatura. I prodotti che uscivano dal cotonificio venivano spediti in America dove Achille Ven-zaghi, fin dal 1887, compì una serie di viaggi, compagno di Enrico Dell’Acqua (n. 28) al quale fornì un sostanzioso apporto finanziario. In seguito si recò in Egitto e in Turchia per aprire sboc-chi alla produzione della sua ditta che nel 1906 diventò Società Anonima con il nome di Cotonifi-cio Venzaghi. Nel 1912 Achille Venzaghi fu nominato Cavaliere del Lavoro. Egli non si dedicò solo allo stabilimento, ma fu anche attento alla città natale e non vi è istituzione che non lo abbia visto in qualche modo partecipe, a partire soprattutto da quelle assistenziali, principalmente dalla Congregazione di Carità alla quale destinò generosi lasciti. Fece parte del Comitato per le Case Popolari ed Economiche e lui stesso fece costruire diversi lotti di case operaie per le proprie maestranze. Istituì anche un fondo pensioni per i dipendenti del cotonificio diventati inabili in se-guito alla guerra 1915/1918 ed una cassa di maternità per le operaie gestanti. Fu anche Consigliere comunale (dal 1899) e assessore (dal 1902), e consigliere dell’Unione Cotonieri e della Banca di Busto Arsizio. Morì a Milano l’11
Agostino Marcora
Ambrogio Riganti
(Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966)
Agostino Marcora
Olio su tela, cm. 70 x 50
Nato il 16 marzo 1875 da Giuseppe e da Battistina Colombo, Agostino Marcora Farascèn entrò ancor giovane, con i fratelli Angelo e Carlo, nella ditta paterna, la tessitura meccanica Giuseppe Marcora fu Gaspare, fondata nel 1889.
Nei suoi stabilimenti – uno a Busto Arsizio, in via Lualdi, un altro a Dairago ed un altro ancora a Furato di Inveruno – si producevano stoffe per pantaloni, flanelle, oxford e zephir per lesportazione nellAmerica Latina e nelle Indie Inglesi.
Tenace nel lavoro e riservato nei sentimenti, come si legge nelle necrologie, Agostino Marcora fu anche meritevole atleta e tra i fondatori della Pro Patria Ginnastica di cui diventò vicepresidente. Insieme con altri industriali, quando si trattò di costruire la palestra di via Concordia, contribuì in solido, diventando azionista per un quarto del capitale allora versato, cedendo al momento della realizzazione della palestra di via Ariosto ogni diritto sul vecchio fabbricato di via Concordia.
In occasione della V Mostra Internazionale del Tessile, Agostino Marcora fu insignito della medaglia doro per la sua più che cinquantennale attività nellambito dellimprenditoria tessile.
Scomparve il 19 gennaio 1957 nella sua casa di via Lualdi, presso San Rocco, casa caratteristica per una colombaia svettante al sommo del palazzo, purtroppo demolita nel marzo 2007.
Agostino Pietro Colombo
Pietro Sezenna
(attivo a Milano allinizio del XX secolo)
Agostino Pietro Colombo
olio su tela, cm. 78 x 58
Chissà quali prodotti commerciava Agostino Pietro Colombo, nato a Busto Arsizio nel 1847 da Ambrogio e da Angela Ferrario e sposato con Antonia Guzzi (Guzèta). Essendo senza eredi diretti ed essendogli premorta la moglie, il Colombo, alla scomparsa avvenuta il 3 giugno 1898, lasciò alla Congregazione di Carità, in quegli anni bisognosa di tante offerte per lammodernamento dellOspedale, buona parte dei suoi averi fra cui la casa dove abitava in via Novara (ora Lualdi) 8.
Il suo loculo, accanto a quello della consorte, è ancora visibile nellarcata B 1, sotto il portico che conduce nel primo ampliamento del cimitero.
Aldo Venzaghi
Mario Ornati
(Vigevano, Pavia, 1887 – Milano, 1955)
Aldo Venzaghi
Olio su tela, cm. 72 x 57
Aldo Venzaghi nacque a Busto Arsizio il 16 dicembre 1894 da Pietro (n. 35), comproprietario del Cotonificio Venzaghi con i fratelli Achille (n. 29) e Luigi, e da Giovanna Bernocchi (n. 55), figlia di un grande industriale tessile legnanese.
Dopo gli studi, ancor giovane, Aldo Venzaghi prese a lavorare nella ditta di famiglia e si stava prospettando per lui un fervido avvenire, ma le vicende sfortunatamente volsero in altro modo. Sopraggiunta la guerra, fu arruolato come furiere nella Regia Marina; durante il servizio militare contrasse la polmonite, allora incurabile, e, a causa di questa, venne a mancare allospedale militare di Roma il 6 giugno 1918.
Un altro bel ritratto di Aldo Venzaghi, opera di Riccardo Galli, offerto dalla famiglia, è conservato presso la sede bustese dellAssociazione Marinai dItalia.
Amalia Thomas Bossi
Pietro Sezenna
(attivo a Milano all’inizio del XX secolo)
Amalia Thomas Bossi
Olio su tela, cm. 76 x 57
Nata a Milano nel 1826 da Giuseppe Thomas e Giulia Parisot, famiglie più che benestanti (un Achille Thomas aveva una filatura in località Gabinella a Legnano) e di buona cultura, Amalia sposò il bustese Ambrogio Bossi fu Carlo Cesare, titolare di una ditta e appartenente ad uno spettabile casato del borgo, imparentato, tra laltro, con i Tosi di via San Michele, ottimi cugini, come la signora li nomina nella copia semplice del testamento conservato presso larchivio dellOspedale. A proposito di questo, Amalia Thomas lasciò la metà delle sue sostanze, che annetteva la casa civile del Bossi fu Carlo Cesare in vicolo Pace (via Novara), alla nipote Amélie, figlia di Camillo Thomas premortole, e laltra metà alla Congregazione di Carità la quale istituirà uno o più letti nel ricovero dei Cronici al nome della famiglia Bossi. In un successivo codicillo (1904) la Thomas stabilì che il ricavo della vendita degli oggetti nelle case Bossi venisse destinato alla Congregazione di Carità per lOpera Pia del Baliatico. Amalia Thomas Bossi, che rimase vedova di Ambrogio il 23 marzo 1893 e morì il 14 agosto 1910, ricordò nel suo testamento anche la sua Parrocchia di San Michele. Oltre a 1.300 lire per messe ed uffici, la signora donò, perché fosse sistemata sopra la porta maggiore della chiesa, la grande finestra a vetri colorati rappresentante la Vergine col Bambino e altre figure, che in parte era nellatrio di casa Bossi e in parte incastrata nella camera del bagno. La vetrata, di gusto neogotico, è tuttora visibile sulla controfacciata della chiesa.
Angiola Ottolini
Studio Consani, Mascheroni & Sezenna (attr.)
(attivo a Milano agli inizi del XX secolo)
Angiola Ottolini
Olio su tela, cm. 58 x 46
Figlia di Carlo (n. 6), commerciante e possidente, e di Giovanna Crespi Andreona, Angiola Ottolini nacque nel 1821 e crebbe in una famiglia che, pur nellagiatezza, la educò al rigore ed allattaccamento alla religione. Per questo nella sua lunga esistenza Angiola si distinse particolarmente nelle opere di assistenza. Infatti risulta socia fondatrice dellAsilo Infantile SantAnna, avendo offerto lalta somma di lire 1.100, ed il suo nome apparve anche nellannosa causa Biotti sempre comunque per la sua disponibilità.
Morì il 28 dicembre 1907 nella casa di famiglia in via Turati e le sue ingenti sostanze andarono alle chiese da lei assiduamente frequentate, agli istituti di beneficenza e allOspedale sempre bisognoso di lasciti per via di ampliamenti e ristrutturazioni incessanti.
Angioletta Cranaghi Brusatori
Angelo Galloni
(Fara dAdda, Bergamo, 1902 – Saint-Louis, Missouri (USA), 1951)
Angioletta Carnaghi Brusatori
Olio su tela, cm. 96 x 74
Angela Luigia Carnaghi, da tutti però chiamata Angioletta, nacque a Busto Arsizio il 29 maggio 1907 da Carlo (n. 96) e da Maria Teresa Ferrario (n. 95) e si coniugò con Santino Brusatori (n. 100) che nel 1926 fondò un cascamificio.
Angioletta Carnaghi fu sempre al fianco del marito nelle sue molteplici iniziative e quando morì ella riservò un lascito rilevante che permise la nascita della Fondazione Carnaghi-Brusatori che si prefigge il miglioramento culturale e laggiornamento professionale dei medici e del personale ospedaliero.
Angioletta Carnaghi Brusatori scomparve a Busto Arsizio il 18 gennaio 1977.
Angioletto Garavaglia
Ambrogio Riganti
(Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966)
Angioletto Garavaglia
olio su tela, cm. 70 x 50
Angioletto Leonida Garavaglia, nato il 16 agosto 1913, era figlio di Emilio (n. 67) e di Giovanna De Bernardi (n. 57). Laureatosi in chimica, entrò con il fratello Nino (n. 101) nella ditta di famiglia la Giovanni Garavaglia di Emilio Garavaglia specializzata nella tintoria e nella ritorcitura dei filati e diventata in pochi lustri modello del genere, sia per ogni sorta di istallazione, sia per macchinari rispondenti alle esigenze più minuziose del difficile mercato estero e nazionale.
Angioletto Garavaglia non si dedicò comunque solo allazienda familiare, ma fu anche vicino ad alcune istituzioni bustesi, come il Sottocomitato della Croce Rossa per il quale profuse energie ai tempi della presidenza di Antonio Aspesi. Fu inoltre presidente della Pro Patria Calcio nei suoi momenti gloriosi.
Colpito da improvviso malore mentre percorreva in automobile la strada Gardesana, fu trasportato allOspedale di Circolo di Busto, dove tuttavia nulla i medici poterono fare così che Angioletto Garavaglia si spense tre giorni dopo laccaduto, nel cordoglio generale, il 5 giugno 1959.
Anna Anzini Gabardi
Carlo Bonomi
(Turbigo, Milano, 1880 – 1961)
Anna Anzini Gabardi
Olio su tela, cm. 150 x 90
Nata a Busto Arsizio il 26 ottobre 1866, Anna Anzini andò sposa ad Edoardo Gabardi (n. 53), proprietario di un importante cascamificio con sede in piazza Carducci (ora Trento e Trieste).
Nella sua non lunga esistenza morì il 3 dicembre 1919 si dedicò soprattutto ai figli, alla casa ed alle opere di beneficenza, non trascurando però di essere presente ai momenti dincontro più significativi dellalta società bustese e milanese dei primi decenni del Novecento.
Alla scomparsa, il marito devolse in sua memoria congrue somme agli enti filantropici che lei, da viva, aveva beneficato, per primo lOspedale da poco aperto nella nuova sede verso Gallarate.
Annunciata Ferrario
Luigi Locatelli
(Bergamo, 1904 – Bologna, 1984)
Annunciata Ferrario
Olio su tela, cm. 60 x 40
Annunciata era la terza figlia del cavaliere Antonio (1838-1912), industriale e sindaco della Società Italiana di Esportazione di Enrico DellAcqua, e di Giulietta (1836-1919), e sorella oltre che di Maria, Luigi, Carlo, Pietro e Ambrogio, anche di Giuseppe (1868-1906), sposo di Maria Venzaghi, che da lui ebbe un figlio, Antonio, progettista con Ignazio Gardella del padiglione disolamento dellOspedale (1936-1937).
Annunciata Ferrario, rimasta nubile, stabilì che alla sua scomparsa, avvenuta il 27 gennaio 1940 (era nata il 9 maggio 1865), andassero allOspedale ben 50.000 lire, non dimenticando nemmeno lOspizio dei malati cronici a cui destinò 10.000 lire oltre a mobili e biancheria.
Anselmo Giani
Antonio Introini detto il Piturèl (attr.)
(Busto Arsizio, Varese, 1808 – 1893)
Anselmo Giani
Olio su tela, cm 56 x 44
Nato a Milano nel 1776 da Gio Battista e da Rosa Ronchetti ed imparentato con la prestigiosa famiglia bustese dei Tosi il canonico Giuseppe Tosi era suo nipote Anselmo Giani fu gran proprietario di terre e di immobili, soprattutto a Dairago e a Legnano.
Al momento della scomparsa, avvenuta in Busto Arsizio il 17 maggio 1855, Giani, emulando lamico Andrea Zappellini (n. 7), nominò erede di tutti i suoi beni stabili, capitali fruttiferi, mobili, effetti preziosi, contanti in cassa, il Pio Luogo Elemosiniero della città, riservando lire 5.000 allOspitale che proprio in quegli anni, con non lievi sforzi, stava ampliando la sua sede sullo stradone delle Grazie (ora via Fratelli dItalia).
Antonia Bossi Candiani
Studio Consani, Mascheroni & Sezenna
(attivo a Milano allinizio del XX secolo)
Antonia Bossi Candiani
Olio su tela, cm. 78 x 60
Nata a Busto Arsizio il 9 agosto 1816 da Paolo e da Maria Anna Bossi, Antonia si coniugò con Antonio Radice, comproprietario della Turati e Radice, una grande fabbrica di tessuti con sedi al Mulino delle Grazie di Legnano e a Castellanza, ditta alla quale in seguito si aggregò anche, come titolare, Andrea Krumm.
Rimasta vedova ancor giovane, Antonia si risposò il 20 luglio 1846 con lindustriale tessile Giovanni Candiani e da lui ebbe nello stesso anno una figlia, Aloida Carolina Felicia (n. 20), coniugatasi poi con Giulio Durini conte di Monza.
Donna attenta ai bisogni della popolazione bustese, fece spesso oblazioni al vecchio Ospedale, offrendo anche prodotti agricoli provenienti dai suoi terreni di Borsano; alla scomparsa, avvenuta nel 1905, stabilì per lascito di dare alla Congregazione di Carità, amministratrice del Civico Ospedale, 10.000 lire per il mantenimento di un letto di cui potessero usufruire gli operai degli stabilimenti di proprietà Candiani e Durini che si trovavano a SantAntonio di Olgiate, Gorla Minore e Cairate. Unaltra consistente offerta Antonia Bossi decise di destinarla alla chiesa dei Frati Minori di Terrasanta che stava sorgendo in quegli anni in fondo a via Leonardo da Vinci.
Antonio Tognella
Waifron Torresan
(Villafranca di Verona, Verona, 1903 – Busto Arsizio, Varese, 1982)
Antonio Tognella
Olio su tela, cm 70 x 50
Antonio Tognella nacque ad Arsago Seprio nel 1877 e, pur essendosi trasferito in giovane età a Busto Arsizio, mantenne rapporti con quel paese aprendovi una tessitura meccanica in cui era socio Carlo Schapira (n. 73), conosciuto al Cotonificio Carlo Ottolini dove entrambi furono impiegati. Intorno al 1915 di questa ditta essi diventarono i maggiori azionisti, contribuendo fra le due guerre allo sviluppo del Bustese – così ormai era noto il cotonificio – anche con lapertura di altri stabilimenti a Vertova, Voghera e Pontecurone.
Nel 1943 Antonio Tognella fu nominato Cavaliere del Lavoro.
Questo industriale ebbe particolarmente a cuore le sorti dellOspedale di Circolo e ai tempi della direzione del professor Solaro ne diventò prima consigliere damministrazione (1923-1928) e poi presidente (1928-1952). Per questi suoi impegni, per limpulso dato al Centro Tumori che volle adeguato alle esigenze delle nuove ricerche scientifiche, egli ottenne la Civica Benemerenza della città di Busto Arsizio nel 1957 e nel 1959 una medaglia doro al merito della Sanità Pubblica.
Antonio Tognella si spense a Milano nel 1964.
Allinterno dellOspedale il padiglione di Malattie Infettive, rilevante esempio di architettura razionalista progettata da Ignazio Gardella e da Antonio Ferrario, è dedicato a lui e a Carlo Schapira, proprio perché erano stati loro a volerlo e a finanziarlo.
Nel 1966 fu pubblicato un volume in sua memoria con una prefazione-ricordo di Benigno Airoldi.
Antonio Tosi
Pittore Anonimo (Studio Consani, Mascheroni & Sezenna ?)
(attivo tra Ottocento e Novecento)
Antonio Tosi
Olio su tela, cm. 88 x 60
Nato in unantica famiglia bustese, Antonio Carlo Luigi Tosi, del ramo Giandalèn, figlio di Giuseppe, di professione vetturale, e di Annunciata Tosi Fazini, essendo scapolo, con il suo testamento conservato presso larchivio dellOspedale destinò la Congregazione di Carità ad erede della propria sostanza che annetteva la Cascina Annunciata alla Veroncora e la Cascina Casazza a Sacconago, con lobbligo della costituzione di quattro letti da intestargli, uno dei quali riservato ai degenti di Sacconago. Non essendo bastevole il lascito per questa istituzione, si trascinò fra lOspedale e i parenti una lunga causa conclusa definitivamente solo nel 1914. La Congregazione di Carità accettò in quellanno il lascito, garantendo un ricordo marmoreo al cimitero (irrecuperabile) e legati, come stabilito dal Tosi, alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, allOratorio di San Luigi, al Pio Istituto Ritiro Orfanelli San Giuseppe, alla Società Militare di M.S. LEsercito, sezione di Busto Arsizio, e alla Società Reduci Patrie Battaglie.
Antonio Tosi, che era nato il 25 agosto 1842 e che si fregiava di ben tre medaglie meritate nelle guerre dIndipendenza, morì presso lospedale cittadino il 29 marzo 1905.
Arturo Galazzi
Giannino Grossi
(Milano, 1889 – 1969)
Arturo Galazzi
Olio su tela, cm. 70 x 54
Arturo Galazzi nacque nel 1883 da Giosué e da Maria Ottolini. Il padre, con il fratello Ernesto, era titolare di una ditta con telai meccanici fondata nel 1842. Alla sua scomparsa ed al ritiro di Ernesto, lo zio che preferì dedicarsi alla conduzione della Banca di Busto Arsizio, Arturo Galazzi prese le redini dellazienda di via Indipendenza 2, dove si producevano stoffe liscie e forate, specialità per confezioni di busti per signora, stoffe per cappelli e calzature, tele cotone, africs, domestics, jacquards e ratières.
Ritiratosi con letà a vita quieta, morì tragicamente, strangolato dal proprio giardiniere il 26 novembre 1931.
La moglie, Mercede Turbighio, in sua memoria, raddoppiò le beneficenze testate dal marito, destinando 10.000 lire a favore del Seminario di Venegono e ben 170.000 lire allOspedale di Circolo.
Benedetto Landriani
Salvatore Bianchi
(Velate, Varese, 1653 – 1727)
Benedetto Landriani
Olio su tavola, cm. 185 x 115
A sinistra, sotto i volumi, cartiglio con la scritta: [aet]atis an[norum] 66
Nella mano destra lettera: Aff.mo/Al Mo Illre Sig. Come Fr(at)ello il Sig./Benedetto Landriani Can.co Curo di S. Gi?./Pronotario Foraneo di Busto, e Pieve/[Bus]to Grande/1728
Nato nel 1650 in una famiglia facoltosa di Busto Arsizio, Benedetto Landriani fu per 43 anni curato della Collegiata del borgo e, come recita il necrologio nel Registro dei Morti conservato presso lArchivio di San Giovanni Battista, ha fatto moltissime cose in onore della propria chiesa: i due pulpiti e le cantorie, il Mortorio, la capella del Santissimo Crocefisso, la croce ed altre quasi innumerabili cose.
Inoltre si deve al suo impegno lerezione e la decorazione, ad opera di Salvatore Bianchi e del figlio Francesco Maria, della chiesa della B. V. delle Grazie fatta fabbricare con tante fatiche e molte mie spese.
Nel testamento, stilato nellanno della scomparsa, il Landriani destinò le sue sostanze per lerezione a Busto di un collegio dei Padri Oblati di Rho, che infatti giunsero a Busto nel 1739, lasciando il borgo però già nel 1751 così che leredità del canonico, in seguito alla rinunzia di questordine religioso, passò alla Confraternita del SS. Sacramento ed alla Scuola dei Poveri.
Il Landriani morì nel borgo natale il 28 febbraio 1730.
Benedetto Milani
Carlo Grossi
(Carpi, Modena, 1857 – Milano, 1931)
Benedetto Milani
Olio su tela, cm 75 x 60
Nato nel 1853 da Luigi, già direttore e maestro di filatura della Privilegiata Ditta Francesco Turati, ed in seguito conduttore, con il fratello Giovanni, di un commercio di stoffe, e da Maria Ferrari, Benedetto Milani, fu apprendista nello stabilimento dove il padre era stato direttore; nel 1870 costituì con lo zio la Giovanni Milani e Nipoti, con sede originariamente in via Roma e poi in Strada Milano (ora XX Settembre). Qui la ditta assunse dimensioni imponenti, dando lavoro a quasi mille operai impegnati nella produzione di tessuti di cotone per abiti da uomo, generi fini di imitazioni delle lane, oltre le numerose qualità di tessuti tinti in pezza come diagonali, ratières, jacquards, cork-screw, crèpes, panama e broches per abiti da donna, coutils rigati, rasati, fustagni etc.. I meriti industriali di Benedetto Milani vennero riconosciuti in ambito regionale tanto che nel 1889 fu nominato consigliere della Camera di Commercio e commissario del Museo Commerciale di Milano per il quale si fece promotore del progetto di una mostra campionaria di prodotti italiani di esportazione, mostra che venne inaugurata nel 1890.
Amico di Enrico DellAcqua (n. 28), prese parte alla costituzione della sua Società di Esportazione.
In modo discreto, rispose sempre agli appelli lanciati dagli enti di assistenza bustesi e soprattutto fu generoso con il Santuario del Sacro Cuore ed il Convento dei Padri Minori di Terrasanta che stavano sorgendo non lontano dalla sua casa e dalle sue fabbriche. Ma non mancò di interessarsi dellAsilo Infantile SantAnna e della Congregazione di Carità, istituzioni delle quali fu più volte consigliere.
Biagio Bellotti
Biagio Bellotti
(Busto Arsizio, Varese, 1714 – 1789)
Autoritratto
Olio su tela, cm. 97 x 75
Figlio di Leopoldo e di Aurelia Ballarati, Biagio Bellotti diventò sacerdote nel 1742 e canonico di San Giovanni a Busto due anni dopo.
Accanto a queste professioni il Bellotti sviluppò un’intensa attività pittorica che lo portò a dipingere il presbiterio e l’abside della Collegiata, le volte delle chiese di San Gregorio e della Madonna in Prato e tele destinate ad altre chiese di Busto. Ma lasciò sue tracce anche nei paesi del Varesotto e del Legnanese ed a Milano dipinse tutta la cappella dell’Annunciata nella Certosa di Garegnano oltre ad affreschi profani per alcuni palazzi della nobiltà, sempre nel più raffinato gusto del Settecento lombardo.
Convinto della necessità di dotare anche Busto Arsizio di un ricovero per ammalati, indipendentemente dal diritto di inviarli all’Ospedale Maggiore di Milano, offerse nel 1789 una somma per fondare un ospedale in Busto Arsizio lasciando allo stesso quale avvio della Quadreria dei benefattori lAutoritratto.
Il dipinto fu restaurato nel 1927 dal comm. Carlo Moroni di Milano e ancora nel 2004 da Isabella Pirola con la direzione di Isabella Marelli.
Biagio Gabardi
Carlo Bonomi
(Turbigo, Milano, 1880 – 1961)
Biagio Gabardi
Olio su tavola, cm. 65 x 50
Nato nel 1881 da una famiglia originaria di Cassano Magnago, Biagio Gabardi, dopo gli studi tecnici, trovò occupazione al cotonificio Luigi Candiani, passando poi al Cotonificio di Spoleto, acquistato nel frattempo da un gruppo di industriali bustesi. Presto però fece ritorno a Busto Arsizio, e, impegnandosi nella vita politico-amministrativa, diventò consigliere comunale ed assessore.
Nel 1914 fu nominato procuratore del Cotonificio di Solbiate, già filatura Ponti e cotonificio Furter, ma presto ne diventò direttore generale e, nel 1939, presidente.
Consapevole delle esigenze degli industriali tessili, fondò nel 1915 lUfficio Cotoni con sede presso il Ministero dellIndustria, Commercio e Agricoltura a Roma.
Trasferitosi a Milano, ricevette nomine di grande importanza e prestigio: fu, infatti, consigliere di amministrazione di numerosi enti fra cui la Fabbrica del Duomo, lUniversità Cattolica e la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
Cavaliere di Gran Croce della Corona dItalia, ebbe per decreto reale il diritto di fregiare il suo nome del titolo di N.H.
Morì a Milano nel 1941.
Carlo Betti
Ambrogio Riganti
(Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966)
Carlo Betti
Olio su tela, cm. 46 x 54
Nato il 13 settembre 1878 in una famiglia non originaria della nostra città, Carlo Betti si accasò con la bustese Giuseppina Bossi (n. 70) da cui non ebbe figli.
Da persone benestanti quali erano, essi trascorsero la loro esistenza partecipando, sia pure con una certa riservatezza, alla vita sociale e culturale della città, non mancando di essere presenti, sempre, dove si manifestava il bisogno. Lo provano la loro disponibilità nei confronti delle opere di beneficenza del Santuario del Sacro Cuore, di cui erano parrocchiani, e le loro offerte allerigenda chiesa dei Santi Pietro e Paolo, voluta da don Paolo Cairoli, e, particolarmente generose, allOspedale di Circolo.
Carlo Betti si spense il 7 giugno 1942.
Carlo Carnaghi
E. Simana ?
(attivo nel XX secolo)
Carlo Carnaghi
Olio su tavola, cm. 92 x 72
Carlo Carnaghi, di Francesco, il 16 giugno 1908 costituì una collettiva per la fabbricazione, vendita ed acquisto di tessuti con Vittorio Ferrario di Enrico, stabilendo la sede in via Mazzini 45.
Nel 1907 sposò Maria Teresa Ferrario (n. 96), sorella di Vittorio, che gli diede Angela (n. 106), in seguito sposa a Santino Brusatori, titolare di un importante cascamificio. Anche per ricordare i genitori Angela decise di destinare alla sua scomparsa il patrimonio familiare ad una fondazione a nome Carnaghi-Brusatori presso lOspedale di Circolo, fondazione che affiancava – ed affianca tuttora – lo stesso nellapprofondimento culturale e nellaggiornamento professionale dei medici e del personale sanitario.
Carlo Carnaghi scomparve a Busto Arsizio nel 1945.
Sul retro di questa tavola è possibile vedere un altro ritratto, incompiuto, del Carnaghi.